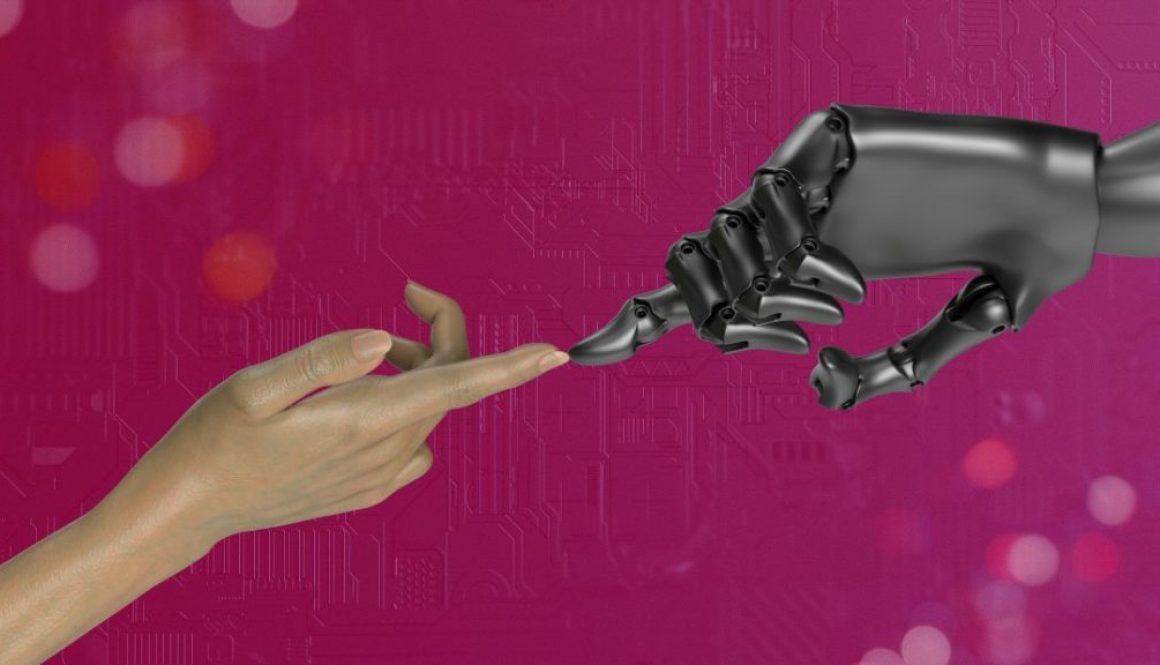L’umanità in outsourcing: arriva l’era della sostituzione
C’erano una volta gli avatar. Figure digitali, mezzi corpi, sagome animate che ci rappresentavano in ambienti virtuali. Erano i nostri sostituti in punta di pixel, un gioco, una proiezione, una presenza simbolica nei luoghi dove il corpo non arrivava: una chat, un videogioco, una piattaforma. Nessuno li prendeva troppo sul serio. Ma forse da lì è cominciata una lenta e silenziosa abitudine: quella di accettare che “esserci” potesse significare anche non esserci davvero.
Poi sono arrivati gli assistenti vocali, i chatbot, i corpi meccanici, le intelligenze artificiali che imparano, si adattano, imitano. E così la presenza si è fatta più densa. Oggi non si parla più di simulazioni, ma di repliche. L’umanoide, a differenza dell’avatar, non è solo un segno. È forma, struttura, movimento. Lavora. Combatte. Decide. Sostituisce.
Succede a Torino, dove apre la prima fabbrica europea di umanoidi: 185 centimetri, 120 chili, articolazioni flessibili, sensori e algoritmi. Sono i Phoenix e non hanno pretese di coscienza – per ora – ma sono progettati per agire dove prima c’era una persona, compiere mansioni ripetitive, resistere alla fatica, adattarsi a nuovi contesti. “Un supporto all’uomo”, dicono. Ma intanto l’uomo si sposta, diventa sorvegliante, programmatore, tecnico. O, in certi casi, esubero.
E succede anche in Ucraina, dove la guerra si combatte sempre più spesso con droni, spider robot, automi da trincea. Le immagini di soldati russi catturati da un dispositivo semi-autonomo ucraino non sembrano uscite da un film di fantascienza. Eppure lo sono. È lì che si consuma uno scarto inquietante: oggi si può essere disarmati, messi in fuga o uccisi da una creatura che non è umana, né ragiona come tale, ma è il frutto tecnico di chi ha delegato alla macchina la mira, la forza, la volontà di colpire.
Non è solo tecnologia. È una visione. Una prospettiva del mondo in cui l’uomo viene spostato, reso marginale, disattivato. Si comincia con “i lavori pesanti e ripetitivi”, poi si amplia il raggio. Il robot diventa più economico, più sicuro, più silenzioso. Non si ammala. Non protesta. Non ha sindacati. Non pretende diritti. E l’umano comincia a sembrare un rischio, una variabile scomoda. Da qui all’automazione spinta, il passo non è lungo.
Naturalmente ci rassicurano. Ci dicono che nulla è fuori controllo. Che gli umanoidi saranno ausiliari, non sostituti. Che l’intelligenza artificiale è uno strumento. Che la guerra autonoma è solo l’ultima frontiera della “precisione chirurgica”. Ma il linguaggio cambia la realtà. E la realtà ci dice che il confine tra supporto e rimpiazzo si sta assottigliando.
Basta guardare la storia: si comincia per affiancare e si finisce per sostituire. La calcolatrice doveva servire solo a far di conto, il computer a semplificare, la piattaforma a collegare. Poi sono diventati indispensabili, poi onnipresenti, poi invisibili. E le persone, lentamente, hanno iniziato a sparire. Non da una stanza, ma dai processi decisionali, dalle filiere produttive, dalle relazioni.
Il risultato? Una società dove il lavoro diventa algoritmo, la comunicazione diventa notifica, la guerra diventa remoto. Dove l’essere umano resta a fare da cornice, mentre tutto si muove senza di lui.
E c’è qualcosa di tragicamente simbolico nell’idea che un uomo, oggi, possa arrendersi non più a un altro uomo, ma a un costrutto meccanico. Non c’è trattativa. Non c’è sguardo. Non c’è dubbio. La macchina non fa prigionieri, non ha esitazioni, non è toccata dalla fragilità. È programmata. E un giorno, forse, lo sarà anche per decidere chi è sacrificabile e chi no.
Il vero rischio, in tutto questo, non è che i robot prendano il nostro posto. Ma che lo facciano senza resistenza. Con l’assenso silenzioso di una società che si sta sempre più convincendo che tutto ciò che è nuovo sia buono e tutto ciò che è umano sia imperfetto, inefficiente, obsoleto.
C’è ancora tempo per chiederci dove stiamo andando. E per riscoprire che il progresso non è solo una questione di tecnologie avanzate, ma di idee di futuro. E che in un futuro senza persone non c’è vera intelligenza, né artificiale né umana.
Perché se un domani sarà fatto di umanoidi che costruiscono, robot che combattono, software che decidono e uomini che osservano in silenzio, quel futuro non ci riguarderà più. Sarà un progetto autonomo, autoreferenziale, cieco alla fragilità, sordo alla coscienza.
E allora il problema non sarà aver creato la macchina perfetta. Ma aver accettato di essere diventati, senza nemmeno accorgercene, il suo pezzo di ricambio.
“L’uomo ha creato un mondo di cose fatte da lui come non era mai esistito prima. Egli ha inventato una complicata macchina sociale per amministrare la macchina tecnica da lui costruita. Ma tutta questa sua costruzione lo sovrasta. Egli non sente se stesso come creatore e centro, ma come il servo del Golem che ha creato” (Erich Fromm).